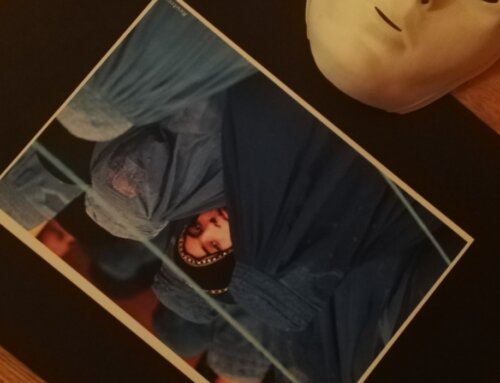Viviamo oggi in una società del desiderio. Che venga chiamato “domanda” o “propensione al consumo”, il desiderio è la materia prima più importante di un’economia in cui la capacità produttiva cresce sistematicamente, anzi, deve crescere semplicemente per mantenere il numero degli occupati, il tasso di profitto, insomma il proprio funzionamento. L’aumento continuo e non la semplice stabilità del prodotto interno lordo è condizione economica necessaria per il buon funzionamento della nostra società. Come un aereo che non sta in aria se non si muove, l’economia in cui viviamo crolla se non accelera, spinta da un aumento della domanda (non tanto dalla sua espansione ai poveri del mondo, che si realizza lentamente e pone “problemi”; ma proprio dalla crescita dei consumi di quanti già hanno molto). Che questa crescita aumenti l’ingiustizia generale nella distribuzione dei redditi e delle opportunità fra le diverse regioni del mondo e le classi sociali, non importa oggi a molti, al di là degli omaggi verbali di rito. Come non importa che lo sviluppo dell’economia comporti in maniera quasi automatica un peggioramento della situazione ecologica del pianeta, per il doppio influsso inquinante dei consumi crescenti e dell’aumento della produzione.
L’imperativo della crescita è fuori discussione. La crescita infinita, con gli interessi composti di una percentuale positiva di aumento ogni anno, è obbligatoria semplicemente per evitare il crollo del sistema. L’impossibilità matematica di una crescita infinita interessa o oggi ancor meno dei suoi rischi ecologici.
Per questa ragione molto materiale, il desiderio (più esattamente l’incremento progressivo delle quantità e della qualità dei desideri socialmente diffusi) domina la nostra società e i suoi costumi, sotto la forma di un’esigenza di “miglioramento” o di “progresso” individuale (e solo poi sociale) che destabilizza e ingigantisce insieme l’Europa almeno da cinquecento anni: incremento economico, demografico, scientifico, dei trasporti, del benessere individuale, delle armi, del divertimento…
Ma è dalla seconda metà del Novecento che essa ha trionfato su tutte le alternative. Come una formidabile forza storica, questa crescita del desiderio attraversa la politica, che a sua volta ha il compito di gestirla, amministrando e misurando “sogni” e “utopie” sulla crescita economica.
Essa è l’oggetto di gigantesche industrie specializzate come quella della pubblicità e del cinema. Fonda l’ideologia capitalistica diffusa ovunque. E’ il criterio su cui si fonda in generale la valutazione della vita e del suo successo: come per il Callicle platonico, “desiderare molto e realizzare i propri desideri” (Gorgia, 492a) è il modello etico dominate del nostro tempo.
E’ sul piano del desiderio che competono oggi le potenze del mondo: sulla capacità di suscitarlo ancor più che di soddisfarlo. Si parla spesso della nostra come di una società virtuale, intendendo con ciò la prevalenza attuale di sistemi tecnici basati sull’illusione di presenza. Anche in un altro senso, però, più psicologico o esistenziale, noi abitiamo un mondo virtuale.
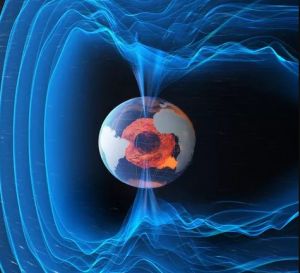 Vale a dire che tendiamo sempre di più a regolare il nostro comportamento sull’espressione del desiderio e sulla sua soddisfazione puramente immaginaria. E’ questo un compromesso inevitabile rispetto alle impossibilità fisiche che limitano la crescita della produzione e del consumo. Non solo i desideri, ma anche la loro realizzazione si svolge nel campo del virtuale, dell’onirico, dell’immateriale. Industrie specializzate badano insieme allo sviluppo del desiderio e alla sua soddisfazione virtuale, spesso definendo la loro attività col nome di comunicazione o di spettacolo.
Vale a dire che tendiamo sempre di più a regolare il nostro comportamento sull’espressione del desiderio e sulla sua soddisfazione puramente immaginaria. E’ questo un compromesso inevitabile rispetto alle impossibilità fisiche che limitano la crescita della produzione e del consumo. Non solo i desideri, ma anche la loro realizzazione si svolge nel campo del virtuale, dell’onirico, dell’immateriale. Industrie specializzate badano insieme allo sviluppo del desiderio e alla sua soddisfazione virtuale, spesso definendo la loro attività col nome di comunicazione o di spettacolo.
Alla base di questo lavoro non c’è solo il “riempimento” o la definizione ritmica del tempo (secondo un modello musicale di base che è sempre sottinteso in ogni forma di “divertimento”; vi è soprattutto la costruzione di significati piacevoli, in cui persone, cose, relazioni sociali sono rappresentati per eccesso, come qualcosa di più di quel che sono, con la condizione ulteriore di permettere un’identificazione immaginaria di chi ne fruisce. I “valori immateriali” che le marche pretendono di aggiungere alle merci sono un esempio tipico di questo processo. La costruzione strategica del senso, la semiotica applicata sono dispositivi essenziali della società del desiderio.
Dal punto di vista di chi usufruisce di queste costruzioni, usualmente definito consumatore, secondo una sineddoche molto significativa, quel che si propone è una sorta di bovarismo di massa (De Gaultier 1921) o una specie di spirito di Pinocchio, per cui il desiderio in quanto tale è la cosa più importante e meritevole di ogni servizio, sia pure, per l’appunto, illusorio.
Un salto nell’illusione compiuto sempre più di frequente, sul piano personale, invece che su quello ideologico e collettivo, che ha qualcosa di inquietante. Ma che presenta l’indubbio vantaggio di scaricare almeno in parte la crescita del desiderio nell’inesauribile spazio della possibilità, dando tregua alla realtà e ai suoi limiti.
L’illusione del resto (in ludus) è il modo di far entrare l’illuso in un gioco: spazio-tempo determinato e chiuso, dove le azioni non hanno lo stesso significato che fuori e sono prive di conseguenze esterne, anche se vengono compiute “seriamente” e con la massima partecipazione emotiva.
Mentre la filosofia e le scienze umane che si occupano della vita sociale non sembrano aver afferrato appieno la grande trasformazione implicita nel trionfo di massa di questo atteggiamento, l’hanno compresa da tempo quelle tecniche che si occupano insieme di descrivere le oscillanti percezioni della realtà che si diffondono nella vita sociale e di soddisfarle virtualmente. Così il giornalismo, con le “soft news” di “attualità”, che hanno il senso di diffondere le mode sotto il pretesto di informare su di esse; la televisione, soprattutto quella che usa come materia di spettacolo le vicende di persone “vere”.
Così il teatro, per esempio nella forma del monologo autobiografico. Così soprattutto il marketing dei beni di consumo di massa e quel tipo di sociologia pratica che gli è intimamente legato, sotto il nome di “ricerche di mercato”. In questo contesto gli esseri umani definiti come consumatori non possono naturalmente esercitare alcun progetto di “trasformare il mondo”, pratica evidentemente difficile e complessa, che comporta fatica, rischi, pazienza, responsabilità progettuale – e che potrebbe essere controproducente allo sviluppo economico.
Quest’impossibilità progettuale viene comunemente definita oggi, in maniera molto ideologica “fine delle ideologie”. In realtà l’ideologia, o l’utopia sono a loro volta espressioni di desiderio. Il desiderio, negando la realtà effettuale per immaginare al suo posto una situazione più soddisfacente, è per definizione sovversivo. Mostra che la realtà è porosa, intessuta di altri possibili stati di fatto che non ci sono ma potrebbero realizzarsi – anzi, scommette su tale trasformazione. Il desiderio implica l’alterità e il cambiamento. Ma questa dimensione utopistica, sovversiva del desiderio è celata, nella nostra società, dietro una fitta rete di definizioni su ciò che è possibile o doveroso desiderare. Non bisogna desiderare la gloria e le grandi azioni, almeno non dopo Don Chisciotte.
Non bisogna desiderare il Cielo e la Salvezza, almeno non sul serio. Il catalogo dei desideri è contenuto fisicamente nei centri commerciali, riccamente illustrato in televisione e sui giornali, continuamente reiterato. Bisogna desiderare quel che già c’è, quel che è in vendita, quel che appartiene ad altri. L’invidia lecita è quella economica, perché, come sapeva già Adam Smith, dal desiderio di arricchire individuale, nasce l’arricchimento collettivo. E questo, come abbiamo visto, è necessario per il funzionamento di un sistema – quello capitalistico – che non può semplicemente essere stabile senza entrare in crisi. Dunque la limitazione qualitativa del desiderio, il suo addomesticamento, è necessario come la sua crescita quantitativa.
Ne deriva un senso di sostanziale immobilità, che si nasconde dietro l’apparenza del movimento, del progresso tecnologico, del trascorrere delle mode. Anche quando si introducono delle novità (nuove musiche, nuovi prodotti, nuove fogge del vestire) esse sono descritte come un fatto, la moda prossima ventura: così fan tutti (o lo faranno fra un momento). O così fanno già quei pochi “esclusivi” che meritano di essere imitati: anche il desiderio comporta una gerarchia di accesso all’informazione, fenomeno tipico delle mode. Ma è chiaro che il cambiamento è limitato alla superficie delle cose non può né deve investire la loro organizzazione fondamentale, e in particolare la struttura della società. Il mondo del desiderio aspira a cambiamenti minori, ma è sostanzialmente conservatore. Perché il singolo desiderio si realizzi, in maniera fantasmatica o reale, il contesto deve restare intatto.
Questo conservatorismo è però impaziente: non vuole assolutamente rassegnarsi a “comprendere” e ad accettare le cose come sono, in modo da venire a patti con l’onnipotenza della realtà – ciò che dagli stoici in poi e soprattutto nel cristianesimo è stato spesso presentato come la condizione di ogni saggezza possibile, l’oggetto stesso della pratica filosofica. E che di fatto è stato il modo di essere della maggior parte dell’umanità storica.
Al posto di questi due poli – accettazione comprensiva e difficile trasformazione del mondo – messi in alternativa in una celebre tesi di Marx, l’atteggiamento più diffuso e più approvato nella nostra società è per l’appunto il desiderio, o meglio, la sua pratica discorsiva o virtuale: immaginare (far vedere) un altro mondo perfetto – ma solo individualmente perfetto, misurato sui piccoli piaceri del quotidiano: privo dei fasti e della resistenza materiale della realtà, luogo di piacere privato e di felicità individuale, un piccolo paradiso senza implicazioni metafisiche (per esempio un’isola dal paesaggio “incontaminato”, una casa ricca e armoniosa, una vita da ricchi, donne e uomini belli e disponibili) – e rivendicare questo desiderio, per la sola ragione della sua esistenza, come un diritto. Ma non fare molto per realizzarlo, pretenderne soprattutto l’immagine. Trarne una soddisfazione delegata attraverso l’uso dei prodotti che si sono curati di allestire per noi questo bel sogno. Il marketing e la pubblicità che arricchiscono le merci di “qualità immateriali” non fanno che alimentare e sfruttare il nostro bovarismo collettivo.
 La nostra è una società del desiderio. Il desiderio – la sua organizzazione, manipolazione, coltivazione – ha una rilevanza sociale che non aveva probabilmente mai avuto in nessun’altra epoca storica.
La nostra è una società del desiderio. Il desiderio – la sua organizzazione, manipolazione, coltivazione – ha una rilevanza sociale che non aveva probabilmente mai avuto in nessun’altra epoca storica.
Lo studio contenuto in questo libro non è però un’analisi sociologica sull’impatto del desiderio nella cultura contemporanea, né un lavoro teorico sul marketing.
Ha piuttosto l’ambizione di seguirne le articolazioni fra teorie filosofiche, pratiche linguistiche e comunicative, presenze letterarie e mediatiche. E’ sembrato importante tentare un approccio teorico alla nozione di desiderio, che provasse a rendere ragione anche della storia lunga e frammentata della sua presenza nel discorso filosofico.
E’ convinzione di chi scrive che non esista un oggetto come il desiderio: cioè che esso non sia uno, che non sia un oggetto, che non possieda un’esistenza indipendente. E’ evidente che non si può trovare in natura (fosse pure nella natura umana, nella biologia del cervello) una cosa desiderio, esistente di per sé. Ma è chiaro che noi possiamo riconoscere e classificare sotto la voce “desiderio” una serie di comportamenti e di mosse narrative che possiamo ritrovare in tutte le tribù degli uomini e forse anche più in là, fra certi animali superiori. Si tratta dunque di uno di quei concetti che certo sono socialmente istituiti, frutto di una costruzione culturale (di un complesso di costruzioni culturali) ma effettivi, capaci di descrivere realtà esistenti già prima della loro “invenzione” (Searle 1995, Olson & Torrance 1996). D’altro canto, tali pratiche non sono indifferenti o neutre rispetto ai modi in cui sono descritte, ai nomi che sono date loro. E’ il caso, per esempio dell’amore, le cui manifestazioni greche e romane sono assai diverse dall’immagine che noi ce ne facciamo oggi (Vernant 1989, Bettini 2000).
Dunque lavorare per cogliere le oscillazioni di senso e di valore cui il desiderio è stato sottoposto frequentemente nel corso della tradizione filosofica europea non è semplicemente un lavoro filologico di “etimologia del pensiero”, ma una ricerca che mira a rintracciare figure, nodi e alternative ancora aperte oggi. Il desiderio, così come lo pensiamo (o piuttosto lo diamo per presupposto senza rifletterci troppo) nella nostra vita individuale e sociale, è stato anche determinato dallo sforzo di pensiero che si cercherà qui di decifrare. Questo è particolarmente vero per una doppia relazione che definisce il desiderio fin dagli inizi di tale riflessione: quella, estremamente problematica, che lo separa e lo congiunge a un tempo da un lato al bisogno, dall’altra al piacere. Oltre alle analisi linguistiche, alla ricerca storico-filosofica, alla descrizione fenomenologica che è uno strumento indispensabile per comprendere il modo in cui il desiderio appare nella nostra cultura, si sono utilizzati alcuni frammenti di teoria psicologica – a dire il vero, piuttosto psicoanalitica, perché il desiderio non sembra un oggetto molto interessante per gli psicologi cognitivi o sperimentali.
-7-
Due grandi figure si sono intersecati a questa ricerca, determinandone la forma. Il primo è il corpo, cioè la natura fisica del desiderio, il suo radicamento (dal punto di vista soggettivo di chi esercita il desiderio, come da quello dei suoi oggetti privilegiati) nell’organismo umano, che a sua volta appare una realtà naturale sì e biologica, ma profondamente plasmata dalla sua esistenza sociale. la seconda, forse meno prevedibile, consiste nel legame che il desiderio intrattiene con una nozione altrettanto problematica e meritevole di discussione in quanto data per scontata, quella di testo. Questo legame è doppio: da un lato il desiderio, sotto la sua apparenza immediata e perfino inarticolata, rivela una natura testuale – anzi più esattamente narrativa. Ciò che si desidera non è mai esattamente un oggetto, ma un corso di cose che ci mette in relazione con questo oggetto secondo un’organizzazione narrativa.
Insomma, nell’analisi del desiderio non può non venire in gioco un livello semiotico. D’altro canto la nozione di desiderio e quella correlativa di piacere è essenziale per comprendere le pratiche testuali, come ha mostrato per primo in maniera articolata e convincente Roland Barthes (1973): ogni lettura di un testo qualunque risponde a un desiderio del lettore – un desiderio che si pone sul piano dell’enunciazione e che interviene continuamente a influenzare i modi in cui il testo è recepito e “consumato”. Questo desiderio (e il piacere che eventualmente ne deriva) ha relazioni complesse con il corrispondente “desiderio della scrittura”, il piano o l’intenzione che fanno di ogni testo un oggetto strategico. Esistono poi dei desideri che organizzano il piano dell’enunciato, quelli che organizzano l’azione e i programmi narrativi dei personaggi del testo, ma anche quelli che determinano la struttura di valore che sta alla base di ogni semiosi. Anche una semiotica del testo è dunque incompleta senza una teoria del desiderio.
Prima di esser un libro, questa ricerca è stata oggetto di due corsi universitari da me tenuti all’Università di Bologna (1998-99) e di Torino (2000-2001). Ringrazio i miei studenti per avermi aiutato a chiarirmi le idee e con loro le persone che hanno avuto la pazienza di leggere in diverse fasi il mio dattiloscritto e di arricchirmi con le loro osservazioni: Elana Commisso, Maria Bettetini, Monica Fabris, Michela Gallio.
di UGO VOLLI
Introduzione al libro “FIGURE DEL DESIDERIO testo, corpo, bisogno”